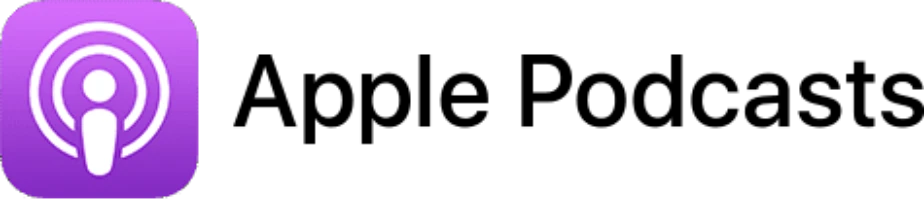A volte mi chiedo se il testo che scrivo sia più efficace se lo interpreto io stesso, oppure lasciare che venga letto e basta. Probabilmente è un dilemma dell’attore che c’è in me.
Lotto contro questa doppia faccia. Da una parte cerco di scrivere nel modo più autentico possibile, soprattutto qui sul diario, dove alleno quella che si chiama «la voce principale». Poi, quando rileggo, provo a restare fedele a quella voce. Da questo punto di vista, il diario è molto utile: mi costringe a semplificare, a cercare di scrivere «come parlo».
Leggevo il suggerimento del direttore di una delle grandi scuole di scrittura americana, che diceva che durante il primo anno gli allievi dovevano tenere un diario, nel quale cercare con tutte le loro forze di «parlare». Questo per evitare che le sovrastrutture accumulate negli anni — insegnanti, maestri, autori — si cristallizzassero, e per liberarsene almeno in quella sede.
Quando scrivo i libri, la mia prosa è decisamente più raffinata: uso allitterazioni, metafore, strutturo gli eventi, e spesso cado nella trappola di essere «troppo forbito». Non sopporto la prosa raffinata o complessa solo per farsi bella. E quando mi accorgo di essere caduto in quella trappola, mi viene l’istinto di tagliare, pulire, semplificare.
Questo nel diario non succede, perché qui non ho velleità autoriali. Anzi, spesso questo è proprio un pregio: un livello base di comunicazione che fa emergere semplicemente il pensiero, il cuore, l’anima.
Scrivere un diario è molto utile. Davvero. Non l’avrei mai detto, ma aiuta in molte cose: a far emergere, durante la scrittura sulla pagina bianca, problemi nascosti dall’inconscio, oppure paure. Inoltre, nel caso del diario d’artista, esiste una componente di condivisione che lo rende comunque «dimostrativo». Quindi non posso trascurarlo.
Mentre scrivo, Eleonora ed Elettra stanno facendo lettura. Mia figlia frequenta la scuola francese, e a quanto pare è molto brava nella lettura ad alta voce… Saranno gli otto anni di letture che il papà le ha fatto a letto prima di dormire? Chissà.
Un altro caffè. Oggi sarà una giornata tranquilla. Ho i miei piccoli obiettivi. Uso un’applicazione di to-do in cui scrivo cosa devo fare, cosa dovrei fare e cosa potrei fare, e poi procedo in ordine. Quando finisco il primo gruppo, apro il secondo, e così via.
Ho quasi finito le cose che devo fare, anche se… molte cose sono nella mia testa e non le scrivo.
Ora lavoro sulla struttura del quarto volume: cinque linee narrative parallele che si intrecciano durante venticinque capitoli.
Stanno litigando perché Elettra non si siede bene mentre fa i compiti. Temo la lite imminente. Partono così, sorridenti, poi badabam, scoppia la lite, e poi sono amiche come prima. Mamma e figlia.
Dicevo, venticinque capitoli e cinque linee narrative che devono continuare la storia che per tre volumi ho costruito con precisione certosina. In questa fase, nella strutturazione, emergono i miei due lati: quello logico-matematico e quello creativo. Lavoro per rispettare la struttura e il metodo, ma essere ancora creativo all’interno dei paletti.
Una saga è come un enorme edificio: un grattacielo di 125 piani, 625 appartamenti, 3125 stanze. Senza un po’ di scienza, il rischio che crolli durante la costruzione è molto alto.
L’altro rischio è che tutta questa richiesta tecnica limiti la creatività dell’autore. Ognuno deve trovare il suo punto di equilibrio, un colpo alla botte e uno al cerchio.
Ecco che Elettra fa la polemica: «Va bene così, mamma?» con quel tono un po’ saccente.
Ho dovuto intervenire. Quando legge, inventa le parole per sembrare più fluida.
Ora legge senza mettere il pensiero.
Black out.
Così diceva il mio maestro di violino. Dopo un’oretta, andavo in black out. Non ero più capace di rispondere, di «essere». E allora bisogna fermarsi, perché non serve a niente continuare. Non entra più nulla.
Quella è una qualità che va allenata: la consapevolezza di essere arrivati al limite. Quello vero. Non quello della stanchezza, ma quello dell’obnubilazione, in cui, a livello creativo, non c’è più linfa da succhiare.
Sono spesso sostenitore dello spingere oltre i limiti, ma ammetto che, per quanto riguarda la creatività, mantenere un margine di morbidezza renda il processo più fluido. Perché quando ci esauriamo e il terreno si inaridisce, il tempo per farlo tornare fertile è molto più lungo del tempo che avrebbe richiesto un filo di riposo.
È la tecnica della rotazione triennale che si usa nei campi in agricoltura: due lavorano, uno riposa. Ecco, forse dovremmo fare così anche noi.
Ora prendiamo la macchina e andiamo dai miei per pranzo.
Non li vedo abbastanza spesso, dovrei approfittarne. Lascio sempre alla scusa della vita la responsabilità del mio essere sfuggente. Su questo devo ancora lavorare molto.
Il tempo qui è troppo poco.
Troppo poco.
Alla prossima pagina.